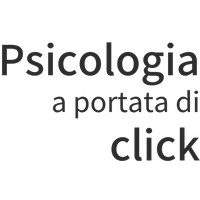Indice
C’è un capitolo nell’ormai conosciutissimo libro “Donne che corrono coi lupi” (di Clarissa Pinkola Estés) che si intitola così: “Alla ricerca del branco: la grazia dell’appartenenza”. Attraverso questa fiaba, si parla della resistenza del nostro istinto di fronte alle difficoltà e della beatitudine che si prova una volta trovato un gruppo cui appartenere (vedi anche la teoria dei gruppi).
Ripercorrendone le scene principali, vedremo qui cosa prova e a cosa va incontro chi sviluppa la sindrome del brutto anatroccolo, cioè quella persona che viene sminuita dagli altri e finisce per sminuire se stessa. Inoltre, capiremo in che modo può impegnare le proprie energie per uscire dalla fastidiosa condizione di emarginazione, bassa autostima e percezione distorta della propria immagine corporea. 
La fiaba del brutto anatroccolo
Il protagonista di questa storia è il brutto anatroccolo. Questo povero anatroccolo nasce e passa il primo periodo della sua vita a sentirsi in difetto. Tutti lo insultano, lo trattano male e lo incolpano di qualcosa che non ha mai fatto ma che gli viene addossato per diritto di nascita. Il nostro anatroccolo si sente brutto perché non assomiglia agli altri fratelli. Per questo viene insultato, fischiato, addirittura beccato sul collo da altre anatre e allontanato da tutti, persino dalla madre ormai esasperata dalla situazione.
Lui non capisce, si chiede ogni giorno cosa possa aver fatto per meritare un trattamento simile e non riesce a rispondersi perché, effettivamente, non ha fatto nulla! La storia prosegue e forse sappiamo già tutti come va a finire. Il brutto anatroccolo si allontana, solo e disperato, e, dopo varie peripezie, finisce per incontrare dei bellissimi cigni.
Accanto a loro, specchiandosi sull’acqua di uno stagno, finalmente capisce: lui non è un brutto anatroccolo, lui è un bellissimo cigno! E, per la prima volta, scopre cosa significa essere accolto con gentilezza, empatia e affetto dai propri simili.

Dalla fiaba alla psicologia: Sindrome?
L’anatroccolo è simbolo della natura selvaggia e dell’istinto che resistono e lottano per la libertà di esprimere la propria reale essenza. I cigni, compagni ritrovati, rappresentano invece la propria famiglia psichica che, riconoscendoci, dona alla persona senso di appartenenza e vitalità.
Il metodo di Estés attinge alle fiabe e ai miti come strumenti per aumentare la conoscenza di sé. Chiunque di noi può, infatti, riconoscersi facilmente nel brutto anatroccolo e lasciarsi colpire dalle sue suggestioni per crescere interiormente. Questo comprendendo con più chiarezza da dove arrivano certe sofferenze e trovando dei consigli che, una volta adattati alla propria realtà, possono rivelarsi particolarmente utili e motivanti.
Saita (2015) descrive la sindrome del brutto anatroccolo spiegando che chi se ne ritrova coinvolto si percepisce come poco attraente, brutto. In più, va alla continua ricerca di modi per sentirsi più desiderabile (per es. attraverso interventi di chirurgia estetica).
Terreno fertile per sviluppare questa condizione sono immagini, etichette e punti di vista. Collezionati più o meno consapevolmente nel corso della propria vita, influiscono profondamente sul modo in cui si va a strutturare l’autostima.
- Interessante anche la lettura proposta in The Substance (2024) con Demi Moore
Chi può rivedersi nel brutto anatroccolo?
Il brutto anatroccolo, oggi, può essere chi ha un orientamento sessuale diverso da quello di coloro che lo circondano, chi ha hobby “particolari” e, quindi, ritenuti più bizzarri (come praticare lotta libera nel tempo libero, soprattutto se sei una ragazza). Ma anche chi ama vestirsi in modo esuberante o iscriversi a corsi di studio non molto conosciuti, insomma, chiunque si allontani, anche di poco, dai soliti schemi.
Quello che Estés vuole ricordarci, riprendendo questa storia tra le pagine del suo libro, è che spesso il nostro valore dipende dal modo in cui gli altri sono abituati a raccontare la nostra esistenza. Se sono deriso, svalutato, offeso, sminuito, finirò per credere di essere un brutto anatroccolo anch’io. Allora, se vorrò stare bene, dovrò necessariamente prendere le dovute e sane distanze da queste narrazioni che non mi appartengono e creano in me sofferenza. Come? Anche in terapia, lavorando sulla mia autostima e il mio senso di autoefficacia.
L’atteggiamento per rispondere all’emarginazione
L’ideale sarebbe riuscire a far cambiare l’atteggiamento di chi ci circonda, certo. Questo però non sempre è possibile e non è realisticamente realizzabile per una marea di motivazioni che cambiano da caso a caso. E, allora, è fondamentale ricordarsi che non siamo fossilizzati su quel metro quadrato di terreno in cui ci troviamo. Infatti, possiamo spostarci, andare alla ricerca di altri “cigni”, come noi, capaci di riconoscere il nostro valore.

È improbabile avere la fortuna di trovare sin da piccoli altre persone con cui condividere le proprie reali passioni e il proprio vero modo di essere. Accettare la diversità è importante per la nostra felicità e può arricchirci. Allo stesso tempo, è importante nutrire la nostra curiosità innata e trovare altre persone a noi affini con cui condividere aspetti che ci accomunano.
E, più di tutto, è salvifico imparare a riconoscere il proprio valore da sé. Questo coltivando autonomamente quella che è la nostra stessa storia. Perché ci saranno sempre momenti nella vita in cui ci toccherà farcela da soli. Sarà essenziale non farsi abbattere dai pareri nocivi altrui che, spesso, si rivelano essere critiche infondate – come nel caso delle ostilità delle anatre della nostra storia.
Lo sai che Leonardo da Vinci veniva deriso dai suoi contemporanei per via del suo interesse nel sezionare cadaveri equini e umani o dell’occuparsi di questioni scientifiche che lo facevano guadagnare “poco”? Oggi è elogiato come maestro ineguagliabile, ma all’epoca anche lui veniva talvolta messo in disparte e sminuito da chi lo circondava. Possiamo con certezza affermare che Leonardo era semplicemente un cigno di cui le anatre del suo tempo non erano capaci di percepirne il valore. Non sempre è possibile essere riconosciuti da chi ci circonda.
Questo anche in casi in cui la bravura è lampante come per Leonardo, ma questo non significa che sia il caso di arrendersi o che il nostro valore perda qualcosa. È necessario lavorare su di sé, sulla propria autostima. Anche sul modo in cui decidiamo di narrare la nostra storia per concedere ai nostri limiti e ai nostri punti di forza la giusta dignità che meritano.
Letture consigliate
Per approfondire la conoscenza che hai di te stesso attraverso miti e storie, potresti trovare molto interessante il best seller “Donne che corrono coi lupi” (1992) della psicoterapeuta junghiana Clarissa Pinkola Estés.
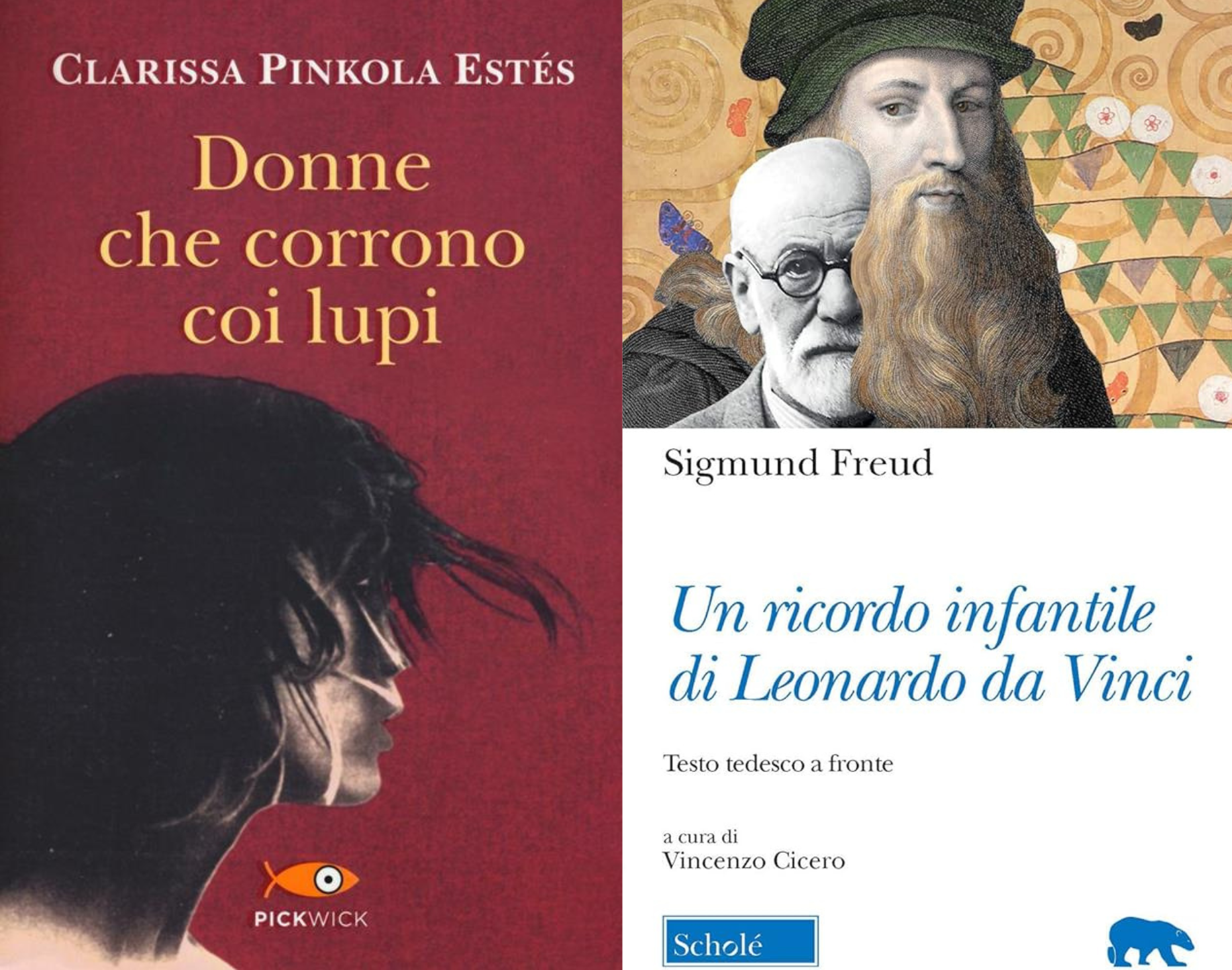
Ti ha colpito scoprire che anche Leonardo da Vinci aveva aspetti puramente “umani” e ha avuto una vita travagliata proprio – o, meglio, quasi – come la tua? Allora puoi approfondire attraverso la lettura del testo “Un ricordo infantile di Leonardo da Vinci” (1910) scritto da Freud. Qui, Freud, osserva Leonardo come esempio di personaggio letterario capace di mostrare come difficoltà, traumi, fallimenti ed emarginazione non escludano la possibilità di costruire un’esistenza ricca di straordinaria bellezza.