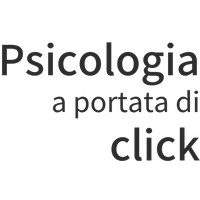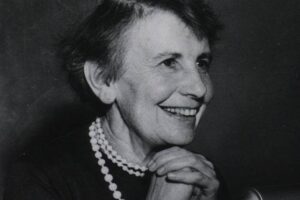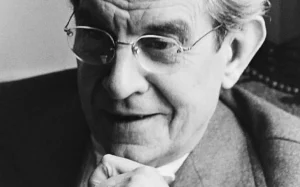Indice
E se invece di lamentarti perché “i giovani ormai parlano a modo loro” ti mettessi a studiare la loro lingua? Questa conclusione potrebbe sconvolgerti, lo sappiamo, ma forse anche intrigarti e spingerti verso un mondo di parole e significati nuovi!
Se ti senti un po’ turbato, probabilmente sei quello/a che potremmo definire un/a boomer e questo articolo fa proprio al caso tuo. Scopriremo insieme cosa significa essere boomer, in che modo vengono distinte e chiamate le varie generazioni, quali strumenti utili esistono per superare il gap intergenerazionale e, infine, impareremo il significato di alcuni neologismi.
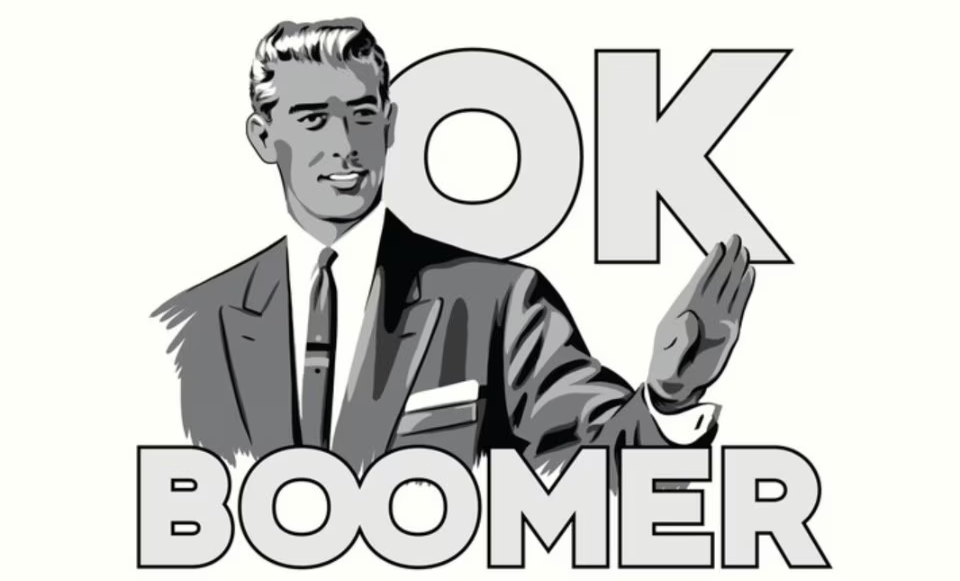
Oh no, sono boomer!
«Le nuove generazioni sono peggiorate!», «Ah, una volta noi non facevamo così!», «Ai miei tempi, tutto funzionava meglio!», «Non esistono più i valori di una volta!».
Ti è capitato di dire una di queste frasi di recente? Beh, se ne hai pronunciata una o più, ho una brutta notizia per te: potresti essere boomer! Forse te l’hanno già detto i/le tuoi/tue figli/e, o i/le tuoi/tue nipoti, o i/le tuoi/tue giovani alunni/e ma sei sicuro/a di sapere cosa significa “boomer”?
Curiosità Ok boomer! Da dove nasce e cosa vuol dire? Questa espressione è diventata espressione della protesta delle nuove generazioni verso chi le accusa di poca motivazione, poca voglia di mettersi in gioco e poco spirito di adattamento. Serve a chiudere la conversazione, indicando un rifiuto di accettare o discutere il punto di vista dell’altro, percepito come assurdo o poco sensibile alle problematiche delle nuove generazioni.
Definizione di Boomer
Se andiamo a cercare sul Dizionario per boomer, nella sezione “rappresentazione”, troviamo questa definizione: Boomer è la «forma abbreviata di “baby boomer” […]. Oggi indica generalmente qualcuno o qualcuna che è rimasto indietro rispetto alla contemporaneità, che non sente dunque la necessità di stare al passo con i tempi e che, a differenza di quanto potremmo pensare, non coincide necessariamente con un’età anagrafica precisa.
È soprattutto il suo atteggiamento superbo, giudicante e sprezzante nei confronti delle generazioni più giovani a caratterizzare la sua natura» (B. Cristalli, “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, p. 59).
Oltre l’età anagrafica
La definizione che viene data dall’autrice del dizionario, Beatrice Cristalli (linguista, ma anche consulente in editoria scolastica per Mondadori Education e Rizzoli Education, e formatrice), fa capire come essere boomer implica un atteggiamento specifico che va molto oltre la semplice età anagrafica.
Sei boomer se fai parte di una generazione “adulta”, che si distacca dalla giovane cultura nascente, estraniandosi e rifiutando i neologismi del mondo contemporaneo. A livello pratico, cosa significa?

Significa portare avanti un gap intergenerazionale, obbligandosi a una sorta di rifiuto rispetto al cambiamento e all’evoluzione intrapresa dalle generazioni nascenti. A questo punto, una volta percepito il distacco, si diventa appunto “boomer” agli occhi delle “giovani” generazioni. La tendenza principale è quella di un atteggiamento dispregiativo verso i problemi espressi e rivendicati dalle nuove generazioni: mancanza di lavoro, innalzamento del costo della vita, cambiamento climatico e conflitti mondiali.
Man mano che si va avanti, ogni giovane generazione apporta il proprio contributo culturale nel mondo in cui vive. È inevitabile e porta con sé molteplici sensi evolutivi che concedono un ricircolo di idee, saperi e convinzioni. Non sempre si tratta di aggiornamenti in positivo ma, in ogni caso, questo rappresenta una mobilità che ci consente di sfuggire alla semplice staticità – che, in ogni caso, bene non fa. È proprio questo cambiamento, in sostanza, che è parte integrante e fondamentale dell’evoluzione umana e che ha, nel corso del tempo, dato forma alla stessa lingua italiana.
Non proprio un complimento!
In quest’ottica, si capisce ben presto come ogni individuo che decide di avere un atteggiamento di rifiuto e di disprezzo nei confronti dei nuovi modi di dire e di esprimersi, finisca per essere considerato, non in modo troppo lusinghiero, un/a boomer. Come spiega Cristalli, «la parola boomer, registrata nel 2020 dall’Enciclopedia Treccani come neologismo, è il simbolo di uno sbilanciamento generazionale che è molto legato agli oggetti generazionali di chi lo pronuncia e lo usa ironicamente come dispregiativo, perciò potremmo dire che è un concetto ancora recente, soggetto a continui mutamenti» (B. Cristalli, “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, p. 60).
Cultura come unione
Cosa sarebbe auspicabile? “Nuove” e “vecchie” generazioni dovrebbero comprendere che la cultura, nelle sue svariate forme e peculiarità, dovrebbe servire – anche tramite le sue esplicite divergenze – ad arricchire e non ad allontanare. A maggior ragione se si rientra anagraficamente all’interno della categoria delle persone “adulte”, bisognerebbe rendersi consapevoli che l’apertura, l’accettazione e l’accoglienza dovrebbero essere principi cardine della vita di chi sta esperendo la propria adultità. In soldoni, ci si aspetterebbe, in teoria, che proprio gli adulti siano capaci di accogliere ciò che le nuove generazioni stanno via via costruendo, innanzitutto impegnandosi a comprendere questi nuovi bagagli culturali.

Uno strumento imprescindibile
Il testo che abbiamo citato in questo articolo, Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni, mira proprio a comprendere il gergo della Gen Z (e non solo), permettendo al lettore di lasciar andare pregiudizi e stereotipi. Ad esempio, ci fa riflettere sul fatto che ci siamo già abituati ai neologismi di studiosi illustri come Dante, d’Annunzio, Leopardi e Pascoli. Quindi, non sta accadendo niente di sospetto o spaventoso: semplicemente, la lingua italiana continua a essere generosa e a prestarsi a modifiche e aggiornamenti continui, in un processo che potremmo definire come naturale.
Generazioni in sociologia
In quest’ottica, ci auguriamo che chiunque, a prescindere da età e personale cultura, possa aprirsi all’altro. Ora facciamo un po’ di chiarezza sul modo in cui i sociologi hanno denominato le varie generazioni e poi vediamo insieme alcuni “nuovi” termini.
Come possiamo leggere su Wikipedia, «a partire dalla fine del XIX secolo, alle generazioni è stato attribuito un nome, sulla base delle comuni esperienze culturali:
- Generazione perduta (1883-1900)
- Greatest Generation (1901-1927)
- Generazione silenziosa (1928-1945)
- Baby boomers o “boomers” (1946-1964)
- Generazione X (1965-1979)
- Generazione Y o “Millennials” (1980-1996)
- Generazione Z o “Centennials” o “Zoomers” (1997-2012)
- Generazione Alfa o “Screenagers” (2013-2027)
- Generazione Beta (2028-2043)» (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Generazione).
Queste etichette sono state realizzate nell’ottica di raggruppare, attraverso la classe di età, quelle persone che sono accomunate da sensibilità simili e, quindi, si ritrovano ad avere molto in comune, soprattutto in un’ottica socio-culturale. Quindi, si tratta di una divisione convenzionale perché, ovviamente, chi è nato nel 1982, e rientra nella classe dei millenials, probabilmente ha molto più in comune con gli appartenenti alla Gen X che con altri della sua stessa generazione, nati qualche anno dopo.
Generazioni: Esistono Davvero?
Come scrive Signorelli, «la domanda che dobbiamo porci non è se le generazioni esistano davvero (la risposta è: no), ma se questa suddivisione sia utile a comprendere i fenomeni sociali. In questo caso, e con tutti i caveat già segnalati, la risposta è invece positiva. È utile un po’ a tutti: a noi per sentirci parte di un gruppo che si confronta e si scontra i precedenti e i successivi, è utile ai sociologi per dotarsi di una (imprecisa) categoria attraverso la quale inquadrare alcuni fenomeni, è utile ai politici e ai loro consulenti per analizzare i temi più vicini alle varie generazioni.
Ma è utile soprattutto – come segnala ancora il New Yorker – al mondo del marketing, che grazie alle generazioni ha trovato un modo incredibilmente funzionale di segmentare i pubblici e i consumatori in base non solo all’aspetto anagrafico, ma anche culturale, tecnologico, di sensibilità politiche, ecc.»
Ora che abbiamo fatto maggiore chiarezza sul modo in cui le varie generazioni vengono distinte tra loro, possiamo concludere come effettivamente ciò che crea il distacco tra una generazione e l’altra è proprio una “distanza” culturale. Quest’ultima si viene a creare man mano che la cultura cambia la sua forma. Per provare a creare un ponte, si rende inevitabile lo studio di questa cultura nascente. Ciò è necessario affinché sia per noi possibile muoverci sia all’interno delle nostre tipiche convenzioni culturali, sia all’interno dei mondi altrui.

Crush e Altri Animali Fantastici
Chiudiamo oggi questo articolo riportando la definizione di cinque parole, ormai largamente diffuse tra le nuove generazioni, sapientemente ricostruite e argomentate dalla linguista Cristalli (cfr. “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, pp. 22-175).
Crush
«L’espressione con cui le nuove generazioni indicano “la propria cotta”. Le sfumature linguistiche del termine mi hanno permesso di capire meglio l’oscillazione entro cui si muove il rapporto dei teen Z con il proprio cuore e la sfera dell’intimità.
Se da un lato, possiamo ricondurre crush, negli esempi di “crush mi ha invitato a uscire” (personificazione) oppure “ho una crush per il mio vicino di casa” (sentimento di attrazione, infatuazione) alla semantica positiva dell’essere innamorati di qualcuno, dall’altro, è la traduzione letterale del verbo inglese to crush, “schiacciare”, “frantumare”, che fa emergere l’altra faccia della medaglia – un amore intenso vissuto completamente oppure non corrisposto, o ancora un’azione da parte dell’amato/dell’amata che delude –, un macigno che presto si scioglierà su di noi, con il quale, a detta dei giovanissimi e delle giovanissime, si esclude ogni possibilità di dialogo.
Ecco perché Jean M. Twenge parla di catching feelings (“contrarre un sentimento”) quando i giovani definiscono la nascita di un attaccamento emotivo a una persona: “un’espressione evocativa, il cui sottinteso è che l’amore sia una malattia a cui sarebbe meglio sfuggire”» (B. Cristalli, “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, pp. 23-24).
Ghostare:
«Prestito parzialmente adattato del verbo to ghost, con l’aggiunta del suffisso italiano -are, è un termine attestato già nel 2015, quando iniziarono a diffondersi le prime applicazioni di incontri online, Tinder in primis. Valentina Maran, in articolo su «Elle», ne parla così: “la finissima arte del dileguarsi si chiama ghosting: la persona che ami a un certo punto sparisce, fa perdere le tracce, non risponde alle chiamate, praticamente si smaterializza e con lei anche la fiducia nel rapporto” (cfr. V. Maran, “Ghosting: quelli che spariscono e non li senti più”, Elle.it, 10 settembre 2015 in B. Cristalli, “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, pp. 35-36)».
Shippare:
«Non fatevi trarre in inganno dalla somiglianza con il verbo scippare (la cui pronuncia in effetti è uguale), voce napoletana dall’etimo incerto (forse dal latino parlato excippare, ovvero “levare una pianta dal ceppo”) che significa “strappare” e si riferisce al furto di destrezza, a strappo. Shippare deriva dal suffisso inglese -ship e in particolare dal sostantivo relationship, “relazione sentimentale”, ma ha assunto una sfumatura ben diversa dal significato originario, che, proprio per la presenza del suffisso, sembra rilegato alla dimensione della staticità, come tanti altri termini con -ship (fellowship, friendship e così via).
Shippare significa mettere in moto lo shipping, l’azione di “accoppiamento”, ovvero fantasticare su una coppia ancora non nata e tifare perché la loro relazione si evolva, come registrato dal Merriam-Webster nel 2021 (Words We’re Watching: A New Sense of ‘Ship’). Letteralmente potremmo tradurre l’espressione in questo modo: “vedere bene due persone insieme e sperare che ciò accada”. Quando poi la coppia si realizza nella realtà, le due persone, come spiega Vera Gheno in un approfondimento uscito su Treccani.it, diventano «un One True Pairing (OTP), tanto da portare alla fusione dei loro nomi, come, al tempo, Brangelina da Brad Pitt e Angelina Jolie» (V. Gheno, “Le lingue italiane di Facebook, galassia in espansione”, Treccani.it, 26 marzo 2018 in B. Cristalli, “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, pp. 46-47).
Cringe:
«un mix esplosivo di affetto, pietà, commiserazione. Cringe è un imbarazzo che si è evoluto. … siamo cringiati quando proviamo vergogna per chi non la prova affatto. Se ci pensate, è qualcosa di molto simile a ciò che in italiano esprimiamo con la locuzione “mi vergogno per qualcuno”. … Avete presente quando l’imbarazzo è così insostenibile da voler fuggire o, peggio ancora, desiderare il mantello invisibile di Harry Potter? Ecco, quello. Cringe, per l’Oxford Dictionary, sembra derivare da cringan, un verbo dell’inglese antico che nel lessico bellico indicava “arrendersi”, “piegarsi”, “rannicchiarsi”, e può essere associato anche al tedesco krank, “malato”. … Insomma, con cringe ci si riferisce a una situazione difficile da gestire. Letteralmente significa “indietreggiare per il disgusto”, e ancora “strisciare”. Magari proprio strisciare via dalla vergogna, quindi allontanarsi dal nucleo dell’imbarazzo» (B. Cristalli, “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, pp. 96-97).
Meme:
«La parola meme è stata coniata dal biologo Richard Dawkins nel saggio Il gene egoista del 1976 e nasce dalla radice greca mimema, che significa “ciò che viene imitato”. E fidatevi che la biologia c’entra, perché il meme svolge la stessa funzione dei geni per l’evoluzione biologica, solo che lo fa in un contesto culturale. Secondo Dawkins, il meme è un “virus della mente”, un elemento comunicativo capace di replicarsi e di attecchire nell’immaginario collettivo.
Quando si parla di meme oggi, ci si riferisce quasi sempre a quelli di Internet, ossia contenuti che circolano e diventano molto popolari online e vengono prodotti e consumati collettivamente dagli utenti del web. … Limor Shifman, esperta di comunicazione, ne ha dato un’efficace definizione (L. Shifman, “Memes in Digital Culture”, MIT Press, Boston 2023) parlando del meme come un oggetto culturale che rientra in una sorta di folklore postmoderno» (B. Cristalli, “Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni”, pp. 172-173).
Facci sapere se, dopo questa lettura, ti senti un po’ più giovane!