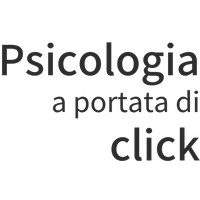Indice
L’estate è appena iniziata e già senti quella consueta voglia di andare in vacanza?
Bene, potrebbe sembrare un tuo desiderio, personalissimo e dettato da tue esigenze peculiari (per es. la stanchezza, l’umidità della tua città che spinge a cercare il mare o la montagna, ferie che si combinano con quelle dei tuoi cari spingendovi a trovare un luogo di incontro in cui divertirvi insieme ecc.). Ma se questa voglia di viaggiare non fosse solo alimentata dai tuoi bisogni interiori ma anche da dinamiche sociali esterne? Ebbene sì, anche rispetto ai viaggi, esistono delle pressioni sociali di cui, spesso, non siamo a conoscenza. In questo articolo, indagheremo in che modo l’agire turistico sia nato e poi si sia diffuso come fenomeno sociale a tutti gli effetti.

Storia del turismo
Prima di capire in che modo la società ci spinga oggi a viaggiare, osserviamo l’evoluzione del fenomeno del turismo nel corso del tempo. La sociologia del turismo si occupa di analizzare il modo in cui si evolvono le motivazioni a viaggiare e quali sono gli effetti prodotti dal viaggio sul soggetto e sulle relazioni che lo coinvolgono. In passato, in parallelo allo svilupparsi del capitalismo, viaggiare era soprattutto una pratica collegata agli esponenti della borghesia che riempivano così il tempo libero. Per le élite, invece, il viaggio aveva uno scopo educativo. Era molto diffuso il “Grand tour” cioè un’esperienza vissuta dai figli degli aristocratici che si recavano in Europa Occidentale (per es. Italia, Francia, Gran Bretagna) per periodi di almeno un anno a scopo educativo e formativo.
In merito, Fussell elenca tre modalità di contatto con il mondo: le “esplorazioni”, ricollegabili al Risorgimento e alla ricerca di ciò che non era ancora stato scoperto; il “viaggio”, connesso alla nascita della borghesia e alla possibilità di sperimentare; il “turismo”, legato al periodo proletario in cui si consumano prodotti preconfezionati e diffusi tramite pubblicità di massa.

Il turismo fino a oggi
I valori dell’“ozio” oggi sono diffusi tra tutte le classi sociali e questo fa sì che chiunque (o quasi) possa sentirsi motivato a inseguire itinerari predefiniti.
A proposito di turismo legato a prodotti preconfezionati, la Scuola di Francoforte ha individuato una “religione del consumo” legata a crociere, parchi a tema e similari che vendono “scenari magici”.
Il primo pacchetto turistico risale al 1838, destinato agli inglesi con un percorso da Wadebridge a Bodmin. Thomas Cook fu il primo pioniere della commercializzazione del turismo occupandosi in un primo momento di viaggi in Scozia, Irlanda, Inghilterra e, dopo, anche di viaggi intercontinentali. Dal XIX secolo in poi, con lo sviluppo di maggiori e migliori mezzi di trasporto, con meno rischi e meno costi, il turismo coinvolge anche la classe media.
Il turismo inizia a essere di massa e a ricollegarsi al tempo libero, spronato sempre più dalla società del consumismo. In particolare, tra il 1920 e il 1930 si diffondono le ferie associate all’idea della vacanza come necessità alla portata di tutti quanti.
Il turismo ha così incentivato l’aumento del reddito nazionale, favorito una maggiore circolazione di denaro, incrementato le attività imprenditoriali e creato nuovi posti di lavoro.
Il turista della società contemporanea viene inoltre definito “eterodiretto” nel senso che si fa organizzare il viaggio da altre persone (come gli addetti delle agenzie di viaggio). Il viaggio, che originariamente rappresentava un mezzo (per spostarsi), oggi si trasforma in un fine.
Fenomeno del sightseeing
L’umano è spettatore passivo, reso tale dal bombardamento di tutti quegli stimoli che lo spingono all’acquisto. McCannell ha evidenziato come il viaggio turistico, a proposito di passività, sia un’esperienza vissuta da tutti allo stesso modo. Alcuni luoghi diventano “sacri” nel senso che rappresentano una tappa imposta socialmente, da visitare, a discapito di altri che nello stesso posto restano in ombra perché fuori dall’attenzione dei più. La definizione di “sightseeing” rileva proprio il fenomeno del “vedere le cose da vedere” e rappresenta quel momento emblematico in cui arriviamo in una nuova città e ci chiediamo «E, qui, cosa c’è da vedere?», aspettando che qualcuno ci risponda con un elenco “preconfezionato” e valido per qualsiasi turista che si appresti a visitare lo stesso luogo.
È strano a pensarci – o perlomeno lo è stato per chi sta qui scrivendo – ma il turismo di massa, che ha preso piede negli anni ’20, poi la vacanza estiva, negli anni ’50, la settimana bianca, negli anni ’70, e il “weekend”, a partire dagli anni ’90, sono tutte modalità di fare esperienza che ci sono state trasmesse e quasi “imposte” dall’esterno.
Motivazioni a Viaggiare
La vacanza rappresenta una delle pochissime utopie gestibili della nostra esistenza. Può spingerci verso l’entusiasmo e ricaricarci le energie ma può anche portare con sé forti dosi di frustrazione e delusione. Spesso, si proietta sul viaggio una necessità di riposo, gioia e felicità che non si è riusciti a sperimentare durante tutto il corso di un anno (o periodi comunque molto lunghi).
Il rischio è di rimanere delusi o di dimenticarsi quanto sia importante cercare di ritagliarsi piccoli momenti di svago e serenità nel corso di tutto l’arco di un anno, limitandosi a “pretendere” di stare discretamente bene solo durante il limitatissimo tempo di una vacanza. Quando si sente un così profondo bisogno di evasione dalla quotidianità, è forse giunto il momento di chiedersi se quella routine che abbiamo creato intorno alla nostra vita non ci stia costringendo a mettere troppo da parte.
Quali i Risvolti Psicologici?
La vacanza è a tutti gli effetti un fenomeno sociale intriso di significati a volte nascosti. Per certi aspetti, potrebbe rappresentare un bisogno legato alla società del consumismo che ci sentiamo in obbligo di, appunto, consumare. Nel caso in cui non si abbia la possibilità di viaggiare (per mancanza di risorse, perché si è vincolati lavorativamente, per prendersi cura di qualche persona cara o altro) o non se ne abbia realmente voglia, tutta questa pressione all’andare in vacanza e soprattutto al mostrarsi in vacanza (per lo più tramite i social), potrebbe spingerci a usare il nostro tempo libero in maniera poco autentica rispetto al nostro reale sentire.

D’altro canto, se vissuto bene e autenticamente, il viaggio concede di rapportarsi con le persone del posto e le loro abitudini. Permette, così, di osservare che c’è una realtà altra rispetto alla nostra, spingendoci a stimolare il nostro spirito di riflessione e soprattutto l’accettazione nei confronti di chi è diverso da noi. Viaggiare avendo voglia autentica di farlo rappresenta dunque un ottimo modo di impiegare il proprio tempo libero.